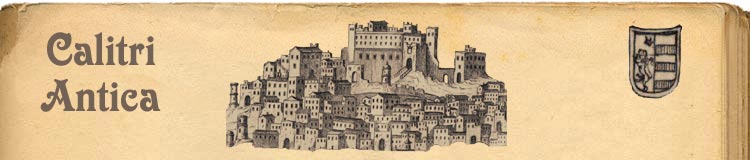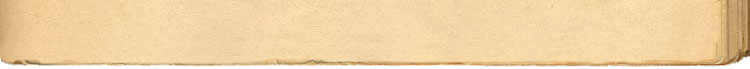Cimiteri e sepolture
(pagina 1/4)
Alcuni anni fa Teresa Di Maio, parlando della confraternita dell'Immacolata Concezione, descriveva con poche efficaci parole l'atteggiamento dei calitrani nei confronti delle cerimonie funebri e della sepoltura:
Le popolazioni povere si sono sempre messe il problema della morte e delle celebrazioni dei riti ad essa connessi come un evento da affrontare con rigore e solennità. A Calitri la nascita, il matrimonio erano vissuti con semplicità e naturalezza e non richiedevano impegni particolari alle famiglie; la morte, invece, esigeva riti che comportavano spese e disponibilità sia della famiglia che della comunità d'appartenenza(1).
La grande diffusione nel meridione del culto di San Michele, l'arcangelo che assiste le anime nel momento del trapasso, è un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che queste popolazioni avevano nei confronti della morte. Una chiesa calitrana era intitolata proprio a San Michele Arcangelo ed era legata in modo stretto alla cura dei defunti; alla chiesa facevano capo la confraternita laicale del Purgatorio, che aveva il compito di fornire ai suoi iscritti assistenza per i riti funebri e per le sepolture, e un Monte detto “dei Morti(2)”.
Nei secoli passati i defunti si seppellivano nelle chiese o nelle immediate vicinanze di edifici sacri e tutte le principali fabbriche sacre di Calitri avevano sia tombe private sia fosse comuni. Agli inizi del Seicento i principali luoghi di sepoltura erano due: la chiesa madre di San Canio e quella del convento francescano di San Sebastiano. Altre chiese furono usate in occasioni eccezionali, come la chiesa di Santa Sofia durante le epidemie di fine XV secolo o quella dell'Annunziata dopo il terremoto del 1694.
Oltre che dai registri parrocchiali, che di solito costituiscono la fonte più diretta per la conoscenza delle usanze funebri di una comunità, si possono ricavare molte informazioni anche dalla lettura degli atti notarili. In questo caso sono stati utilizzati i testamenti di alcuni calitrani raccolti in un protocollo del notaio Nicolantonio Rosa(3), conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, in modo da mettere in rilievo le differenti usanze e possibilità tra le diverse categoria di cittadini.
Ad esempio, in un testamento del 1605 Guglielmo Cioglia, persona di condizione agiata, abitante “ubi dicitur alle casi delli Cioglia”, chiede che i frati accompagnino in processione il suo corpo, che dovrà essere sepolto “dentro l'ecclesia de Santo Sebastiano de Calitro alla sepoltura delli frati con libre 10 de cera all'exequie funerali” e “vestito col'habito di san Francesco per sua devozione”. Per le esequie lascia 20 ducati e 5 carlini ai frati e inoltre, come opere di bene, lascia 10 ducati per la costruzione della cappella di Santa Maria della Santa Croce, 5 carlini “per l'anima sua” alla cappella del Santissimo Sacramento e altri 5 carlini alla cappella del Gesù. Infine lascia alla chiesa di “Santa Maria dello Monte” 5 carlini “che lo arciprete ne compre ogli per la lampa, e detto arciprete habia cura di farla allumare in castiello
(4)”.