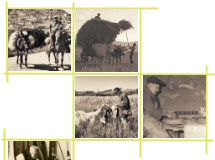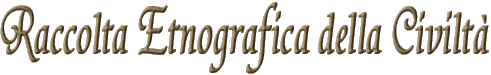| I
Giochi - (I sciuoc')
Fino
a un ventennio fa la strada era il luogo d’incontro
e di svago dei bambini. Essi potevano uscire da soli e giocare
per strada senza pericolo. Se un genitore si assentava i bambini
venivano controllati dalla gente del vicinato. Normalmente le
donne più anziane stavano fuori, davanti alla porta a
lavorare all’uncinetto, a fare la calza ai ferri o a ricamare.
Prima il rapporto che legava le persone che abitavano nella stessa
strada (vicinato) era molto forte; di sera, sia d’inverno,
davanti al focolare, sia d’estate, all’aria aperta
seduti sulle scale, la gente del vicinato si riuniva e passava
il tempo raccontando storie, commentando i fatti accaduti in
paese durante la giornata.
I bambini ascoltavano con attenzione e con un po’ di paura
le storie raccontate dagli anziani (“La criatura r la Cupa”,
lu Scazzamaurieggh’”, “r Masciar’,….).
Molti dei giochi che erano praticati dai bambini risalgono ai
tempi dell’Antica Roma. I pochi giocattoli erano quasi
tutti autocostruiti, alla meglio,.dai bambini: la bambola (pupa)
e “u r’tieggh’” per le femminucce; la
cerbottana (scupp’ttuol’), il flato (fraul’),
la palla di stoffa (palla r’ pezza), le nacchere (r’ castagnol’),
la trottola (curl’) costruita dal falegname, il carretto
(‘U carr’tieggh’), per i maschietti.
Molte volte i bambini si divertivano con gli oggetti che trovavano
in giro.
Portavano nelle tasche dei pantaloni dei veri “tesori”:
- dei pennini “spuntati”, che si chiamavano “sciancati”;
- le “brecce”, cocci di ceramica smaltata che venivano
barattati (cinque di questi pezzi avevano il valore di un pennino “spuntato”);
- dei soldini: cinque centesimi (bisisco), dieci centesimi (pacchiola)
e nichel (quattro soldi), conservati in delle scatolette di latta;
- l’astragalo, l’osso della zampa dell’agnello,
per giocare ai dadi;
- le “galle”, che si raccoglievano sulle querce, e
si facevano mantenere in equilibrio su cannucce di legno.
Quando i bambini correvano questi “tesori“, nelle tasche,
facevano tanto rumore.
Numerosi erano i giochi collettivi: mazza e piuz’, accuvatur’ (nascondino),
spacca maton’, banca cavalier’, s’auza carvon’ (cavallina),
a s’tt’mana (settimana), lu cucuzzar’, ecc…
‘U
curl’
‘
U curl’ era una trottola di legno, aveva la forma di un cuneo
e terminava con una punta di ferro. Per farlo girare si avvolgeva
intorno alla parte conica un laccio (‘u lazz’), e tenuto
stretto un capo dello stesso si lanciava con forza. Srotolandosi
il laccio imprimeva al curl’ un velocissimo movimento rotatorio.
I ragazzi sfidavano la loro abilità nell’uso del “curl’” in
diversi modi: veniva calcolato il tempo che riusciva a girare sullo
stesso punto (la “fitta”), e durante il quale il movimento
era così veloce che la trottola sembrava addirittura immobile,
oppure si contavano le “botte” che due curl si davano
mentre giravano (“passapunton”). Al "curl" del perdente
venivano inflitte delle “cech” di penitenza (cicatrici
sulla sommità del curl’ per deturparlo).
U
r’tieggh’
U’ r’tieggh’ serviva per realizzare delle trecce
di lana o di cotone.
Queste trecce venivano utilizzate per fare “u lazz’” per “u
curl”, oppure, se venivano cucite insieme, si potevano realizzare
sciarpe e coperte.
Per costruire ‘u r’tieggh’ serviva un vecchio
rocchetto di legno e dei chiodini: intorno a questi chiodini veniva
avvolto un filo di lana o di cotone per realizzare delle maglie.
Con l’uncinetto si faceva cadere il filo per ottenere una
nuova maglia, e intanto la treccia si allungava e si tirava dal
foro inferiore del rocchetto. Era un passatempo non solo delle
bambine, ma anche dei ragazzini.
‘U pup’l’
Lu pup' l era una bambola costruita in casa, utilizzando materiale
di uso comune: vecchi mestoli, fazzoletti, pezzi di stoffa, gomitoli
di lana inutilizzata, vecchie magliette per neonati, ed eventualmente
per abbellire la bambola degli accessori fatti ad uncinetto.
Le bambine custodivano gelosamente il proprio bambolotto. Per
tradizione le bambine il 24 giugno, giorno di S. Giovanni, portavano
il loro “pup'l” nella
chiesa di S. Michele per battezzarlo.
Mazza
e pihuz’
Il gioco di mazza e piuz’ consisteva nel colpire con un bastone
(mazza), a più riprese, un pezzetto di legno (pihuz’)
appuntito agli estremi. Il pihuz’ veniva messo a terra e
colpito con la mazza ad una delle estremità; una volta colpito
il pihuz’ si innalzava in aria roteando pronto per essere
colpito una seconda volta e scagliato il più lontano possibile.
Banca
cavalier’
Banca cavalier’ era un gioco al quale partecipavano minimo
sette ragazzi. Un ragazzo (a mamma), che aveva il compito di controllare
lo svolgimento del gioco facendo da arbitro, stava seduto su uno
scalino mentre gli altri si dividevano in due squadre.
Si faceva
la conta (tuocc’) e chi perdeva andava “sotto”:
i ragazzi si mettevano a schiena curva uno dietro l’altro,
in modo da formare un corpo unico. Il primo, che di norma era il
più debole, poggiava la testa sulle ginocchia della “mamma”.
A turno gli altri ragazzi saltavano a cavalcioni sulla schiena
dei avversari posti in fila cercando di sistemarsi il più avanti
possibile.
Una volta che tutti si erano disposti sulla schiena
degli avversari (a volte non si riusciva, perché il primo
non era andato troppo avanti, e si perdeva la partita) la “mamma” controllava
se qualcuno toccava con i piedi per terra.
Il gioco terminava quando
i ragazzi che erano “sotto”, non avendo più la
forza di sostenere gli altri compagni, gridavano “Banca”,
o quando qualcuno dei ragazzi, che erano “sopra”, poggiava
un piede a terra. Nel primo caso si ripeteva il gioco con lo stesso
ordine, nel secondo caso venivano invertite le posizioni.
Spacca
maton’
“U spacca maton” si basava sulla capacità di far cadere
le monete il più possibile al centro di una mattonella.
Era praticato dai ragazzi un po’ più grandi, e spesso
diventava un vero e proprio gioco d’azzardo.
La Cavallina
Il gioco della cavallina (s’auza carvon o Un’ m’bonta
a luna) consisteva nel saltare su un compagno, che nel frattempo
si era piegato con le mani appoggiate alle caviglie, e contemporaneamente
eseguire un comando e recitando una filastrocca.
Alcuni dei comandi da eseguire saltando sulla cavallina e recitando
una filastrocca erano:
•
atterrare con i piedi incrociati (sett’ piroett’),
•
dare un pugno sulla schiena (ott’ ron casciott’)
•
mettere un fazzoletto sulla cavallina (nov’ t’ mett’ la
varda)
•
al turno successivo ognuno si riprendeva il proprio fazzoletto
(diec’ t’ la lev’)
Chi non eseguiva questi comandi ben precisi doveva prendere il
posto del compagno e fare la cavallina.
Lu cucuzzar
"Lu cucuzzar’” era un gioco al quale potevano partecipare
un numero illimitato di giocatori; si sceglieva un capo, che assegnava
ad ogni giocatore un numero, che ciascuno doveva ricordare.
Il capo diceva: “So giut n’do lu’ cucuzzar e
agg’ tr’vat …(e pronunciava un numero a piacere)
cucozz’ mancant’.”
A questo punto il bambino a cui era stato assegnato il numero che
aveva pronunciato il capo rispondeva: “P’cchè probbia …(e
pronunciava il numero detto dal capo) ?”
Il capo aggiungeva: “E quant’ s’no?”
Il bambino interpellato rispondeva un numero a suo piacere e il
gioco continuava con il bambino che era stato chiamato e che doveva
rispondere con la stessa filastrocca; in questo modo tutti i bambini
a turno venivano chiamati.
Se un bambino chiamato non rispondeva subito veniva eliminato;
gli altri allora dovevano ricordare il numero che era stato eliminato,
altrimenti, se lo pronunciavano, venivano eliminati anche loro.
A
S’tt’mana
Prima di iniziare si doveva disegnare, sul terreno di gioco, la “settimana” che
era composta da sette caselle numerate e i giocatori dovevano munirsi
di una pietra piatta e liscia.
A turno i giocatori tiravano la propria pietra nelle caselle, iniziando
dalla prima, facendo attenzione a non farla uscire o farla andare
sulla linea.
Poi veniva eseguito il percorso sulle caselle in modi diversi:
con gli occhi chiusi, con una sola gamba, con la pietra su un dito,
con la pietra sulla testa, sul naso e sulla scarpa.
Quando un giocatore aveva esaurito tutto il percorso aveva diritto
ad entrare in possesso di una casella e gli altri giocatori, per
entrarvi, dovevano chiedere il permesso.
Vinceva chi conquista il maggior numero di caselle.
Altri giochi
- “Pal’ tis’": fare la verticale a testa in giù;
- “Scazz’la tromm’la": capriola;
- “Accuvatur”: nascondino o rimpiattino;
- “Botta c’cata”: mosca cieca;
- "Gioco del cerchio": consiste nel
far girare un cerchio di ferro spinto da una bacchetta lungo la
strada;
- "La Ionna”: fionda per il lancio
di piccole pietre;
- “R’ stampeggh’”: trampoli o staffe rudimentali
fatti con rami di alberi opportunamente scelti;
- Gioco dell’anello: indovinare chi possiede l’anello
nelle mani giunte dei ragazzi;
- “Fierr- f’rrazz’”: toccare oggetti di
ferro (reti metalliche, anelli, cancellate, maniglioni di porte,
ecc…) evitando di essere toccati dalla “mamma” durante
il passaggio da un oggetto all’altro;
- “Stangagghiucc’”: saltare con un solo piede;
- “Scardacopp’l’”: evitare di calpestare
i berretti stesi a terra saltando con un solo piede;
- “Bambaliss’”: altalena ricavata da una corda
legata ad “U” ad un ramo forte di un grosso albero;
- “Zichete zachete”: altalena orizzontale;
- “A fa la guerra”: giocare alla guerra.
|